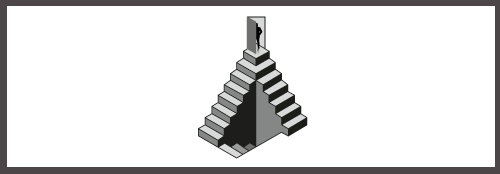20 Apr ANCORA SUL RUOLO DELLA BCE, AL VAGLIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE TEDESCA
Il 5 maggio, nella città di Karslruhe, collocata nel sud-ovest della Germania, potrebbe tenersi un evento decisivo per il futuro dell’Unione Europea, così come l’abbiamo conosciuta. Su vari siti e profili social si fa riferimento a questo importante appuntamento, riportando informazioni che aiutano a comprendere l’importanza della questione, inquadrandola all’interno delle ripercussioni sul sistema economico anche italiano, a seconda dell’esito finale; sorprendentemente peraltro i media main stream sembrano, almeno fino a questo momento, voler ignorare del tutto il tema. E’ interessante analizzare sotto l’aspetto prettamente giuridico quello che potrà accadere.
La Corte Costituzionale Tedesca veniva chiamata a pronunciarsi su una serie di ricorsi presentati da cittadini tedeschi volti a sindacare la congruità delle iniziative prese dalla BCE con il programma (PEPP) di riacquisto sul mercato secondario dei titoli di Stato degli Stati Membri, quale intervento di politica monetaria. Tema già illustrato nel precedente post. Il sindacato riguardava alternativamente la presunta violazione dei Trattati così come dell’identità costituzionale tedesca. In particolare la violazione del principio di stabilità dei prezzi, che entrambi gli ordinamenti tutelano. Ebbene come già illustrato nel precedente post la Corte di Giustizia UE si è già pronunciata nel senso della piena conformità al Trattato. Il procedimento, bifasico, torna quindi avanti alla Corte Tedesca, che dovrebbe ordinariamente limitarsi a prendere atto del pronunciamento della Corte sovranazionale e quindi, semplicemente, rigettare il ricorso pendente.
Ma appare veramente così scontato l’esito della pronuncia della Corte Costituzionale tedesca? Astrattamente possono residuare margini di discrezionalità che potrebbero portare ad un diverso esito del giudizio, fino ad arrivare al suo accoglimento?
Secondo molti commentatori l’esito più probabile sembrerebbe addiritura portare ad un giudizio finale nel senso contrastante rispetto a quello formulato dalla Corte di giustizia UE: ci si aspetta una pronuncia che condanni la politica di riacquisto dei titoli sul mercato secondario, perché contrastante con il principio tutelato dalla Carta costituzionale tedesca.
Del resto, andando a recuperare alcuni passaggi riportati nelle conclusioni rese dall’avvocato generale nel precedente procedimento pregiudiziale sollevato sempre dalla Corte tedesca avanti alla CGUE (causa C- 62/14) si può meglio comprendere l’origine del dubbio, che deriva dallo stesso tenore dei quesiti formulati dalla Corte Tedesca per come la stessa configuri i rapporti tra i rispettivi ordinamenti (l’ordinamento federale tedesco e l’ordinamento comunitario) e dall’analisi svolta dall’avvocato generale nelle sue conclusioni.
In via principale, in più passaggi, si riconosce e si accetta che le due Corti siano chiamate ad operare, prevalentemente in un regime di reciproca e leale collaborazione, senza fare alcun accenno ad una posizione di supremazia della Corte lussemburghese. Lo stesso avvocato generale, con atteggiamento deferente, riconosce nelle sue conclusioni che «nel quadro del rapporto di cooperazione esistente, l’interpretazione dell’atto spetta alla Corte di giustizia. Per contro, il BVerfG ha il compito di accertare il nucleo essenziale inviolabile dell’identità costituzionale e di verificare se l’atto in questione (nell’interpretazione data dalla Corte di giustizia) incida su tale nucleo essenziale». E ciò in quanto secondo il BVerfG, nei «casi limite» di travalicamento di competenze da parte dell’Unione, le prospettive dei due giudici potrebbero non armonizzarsi «interamente», dato che, da una parte, gli Stati membri, sono e rimangono i «signori dei Trattati» e, dall’altro, il diritto dell’Unione occupa una posizione (primazia o primato applicativo) che non è uguale a quella spettante al diritto del Bund tedesco rispetto al diritto dei Länderche si pone, nelle argomentazioni fatte valere dai giuristi tedeschi, come primato di validità assoluto e quindi anche più esteso. Non si esclude quindi un differente giudizio sulla stessa questione da parte dei giudici interni chiamati a valutarla sotto differente e più esteso aspetto.
Tale teoria è conosciuta come teoria dei controlimiti, applicata fin quasi dalle origini della Comunità Europea anche dalla Corte Costituzionale italiana (già con sentenze 183/1973 e 179/1984).
I controlimiti rappresentano un nucleo di principi fondamentali intangibili, normalmente sottratti anche al potere di revisione costituzionale, che costituiscono una barriera all’ingresso di norme comunitarie con esse contrastanti, in quanto l’adesione all’Unione europea, si ritiene, non possa comportare per gli organi comunitari un inammissibile potere di violare i principi fondamentali degli ordinamenti costituzionali degli stati membri o i diritti inalienabili della persona umana.
A seguito dell’ultima riforma del Trattato di Lisbona (2009), occorre tuttavia evidenziare, si è inteso porre fine a questo doppio sindacato, imponendo una radicale riforma alla teoria dei controlimiti, in via evolutiva del rapporto di integrazione, in quanto, all’interno del Trattato stesso si riconosce che spetti alla Corte di Giustizia, nell’ambito del giudizio di pregiudizialità, in primis, anche l’onere di pronunciarsi su tale violazione dei principi fondamentali degli ordinamenti degli Stati membri, dovendoli quindi necessariamente valutare (come quindi deve essere avvenuto nel caso di specie) in via preliminare, intendendosi esautorare, di fatto, le Corti costituzionali nazionali, sul punto.
In verità residuano interpretazioni riguardo alla possibilità di continuare a fare applicazione del principio, giustificando la necessità di un ulteriore vaglio sul presupposto che, come rilevato anche dall’avvocato generale nel passaggio sopra riportato, non può escludersi in astratto che, in circoscritti casi, possa accadere che lo stesso principio o diritto, riceva, nell’ordinamento costituzionale, una tutela più penetrante di quella che riceve in ambito sovranazionale. Ma ciò deve inquadrarsi all’interno di un regime di eccezionalità, al più.
C’è chi non esclude in definitiva che le Corti interne mantengano, anche dopo la riforma posta in essere dal Trattato di Lisbona, il potere di garantire il nucleo essenziale, irrinunciabile e irriducibile dei diritti fondamentali per tutelarsi dalla eventuale violazione perpetrata ai loro danni da parte degli atti eurounitari che superino il giudizio interpretativo della Corte di Giustizia.
E’ bene rilevare che più di recente la Corte Costituzionale italiana, dopo la riforma, ha sposato la linea della persistente possibilità di applicazione della teoria dei controlimiti, nel noto caso Taricco, in materia penale (sent. 179/19), caso che tuttavia non appare strettamente correlabile alla questione all’esame dei giudici tedeschi il prossimo 5 maggio, anche per la materia oggetto di giudizio.
Nel caso concreto infatti non si comprende come l’interpretazione data dalla Corte lussemburghese possa in qualche modo ledere il nucleo centrale, irriducibile del principio (la stabilità dei prezzi) oggetto di tutela anche della Carta tedesca. L’adesione ai Trattati comporta infatti per ogni Stato una cessione di sovranità, che è insita nella stessa definizione di Unione. La Corte di Giustizia ha chiarito che dette operazioni di acquisto rientrino nell’ambito di politica monetaria, anche se non convenzionale; non appaiono distorsive del mercato perché riguardanti l’acquisto in via proporzionale di tutti i titoli degli Stati appartenenti all’Unione, appaiono altresì necessarie (o comunque insindacabili in termini di discrezionalità) nel presente momento storico, non può infine invocarsi da parte dello Stato Tedesco un pregiudizio derivante dall’onere di solidarietà previsto dal programma. Infatti, tale onere di solidarietà riguarda solo il 10 % dei titoli acquistati all’interno del programma e quindi anche eventuali rischi legati al default di uno Stato e contestuale perdite in conto capitale sopportate in astratto dallo Stato tedesco (esposta in quota parte solo nei limiti del 2,5% circa in ragione della regola del capital Key), in caso di ristrutturazione del debito, con l’attivazione delle clausole CAC, potrebbero vedersi compensate dagli utili percepiti in conto interessi sugli altri titoli in portafoglio.
Un eventuale giudizio difforme che verrà reso dai giudici costituzionali tedeschi, che impegni gli organi di governo e la stessa banca centrale tedesca, eventualmente, ad interrompere le operazioni di acquisto legate all’applicazione del programma, non potrà che valutarsi come scelta di egemonia politica volta ad imporre, nell’ambito di ingiustificati rapporti di forza e di supremazia economica, un riesame delle politiche di intervento in questa particolare fase critica legata alla pandemia COVID-19, che non trova giustificazione in punto di diritto.
Non resta quindi che attendere.