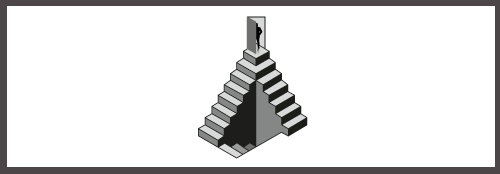11 Mag ANALISI DELLA SENTENZA DI KARLSRUHE/1: L’ESERCIZIO DEL CONTROLLO ULTRA VIRES
Il 5 maggio è stata depositata la sentenza della Corte Costituzionale tedesca, chiamata a giudicare su supposte politiche ultra vires poste in essere dal SBCE, nell’ambito delle politiche di acquisto di titoli del debito pubblico sul mercato aperto (programma denominato PSPP). Breve premessa: sulle questioni oggetto di giudizio si era già precedentemente pronunciata la Corte di Giustizia UE con sentenza del 11.12.2018, su rinvio pregiudiziale della stessa Corte Costituzionale tedesca. Ebbene la Corte di Giustizia UE dichiarava conforme al perseguimento degli obiettivi di politica monetaria la politica di intervento posta in essere dal SBCE.
La Corte Costituzionale tedesca era quindi chiamata a recepire la sentenza della Corte UE, il recepimento avrebbe dovuto portare alla condivisione del giudizio reso dalla Corte UE. Ma così non è stato. La pronuncia della Corte tedesca, infatti, ha affermato chiaramente che la politica di acquisti posta in essere dal SBCE deve ritenersi ulta vires, eccedente il ruolo assegnato a tale organo dal Trattato, oltre a ciò la sentenza della Corte di Giustizia UE non aveva nel caso specifico correttamente valutato, finanche sotto un profilo di effettività, gli aspetti di criticità che detta politica di acquisto evidenziava e pertanto la pronuncia non poteva ritenersi vincolante per l’ordinamento dello Stato Membro, all’esito di un successivo vaglio da parte della Corte costituzionale tedesca.
Merita approfondimento l’impostazione del ragionamento svolto dai giudici tedeschi: con il processo di adesione alla Unione Europea non vi sarebbe stato un completo trasferimento dei poteri democratici, conferiti dal corpo elettorale, al momento dell’esercizio del voto, al parlamento tedesco. Si legge nella sentenza (par. 98 e ss) che il ruolo degli organi costituzionali – governo e parlamento – consiste nel vigilare sulle modalità di applicazione delle regole governanti il processo di integrazione comunitaria, proprio in ragione di una delega di sovranità solo parziale, o comunque, se si preferisce, condizionata; in particolare, nel caso specifico, il controllo riguarderebbe il corretto esercizio di poteri e competenze da parte dell’organo comunitario (BCE) e la corretta applicazione del controllo giurisdizionale sull’esercizio di tale potere, controllo riservato, dall’ordinamento comunitario , in via esclusiva, alla Corte di Giustizia.
Nel caso specifico, oggetto di indagine era la definizione di politica monetaria, competenza che i Trattati riservano alla BCE ,ed in particolare se quel particolare strumento operativo (politica di acquisti PSPP) potesse rientrare nell’ambito della politica monetaria e non piuttosto della politica economica.
La Corte Tedesca tuttavia rivendica a sé una ulteriore valutazione dei contenuti della pronuncia della Corte di Giustizia, sulla base del seguente principio: le sentenze della Corte sovranazionale devono ritenersi vincolanti nei limiti in cui sia stata fatta applicazione di criteri interpretativi comuni riconosciuti negli ordinamenti giuridici degli Stati membri e non possano considerarsi invero oggettivamente arbitrarie.
Non tutte le sentenze della Corte di Giustizia, quindi, possono trovare piena applicazione negli ordinamenti interni, non si potrà produrre tale effetto quando i contenuti delle stesse, interessando principi che trovano tutela costituzionale, non appaiano conformi ad un criterio interpretativo standard immanente nell’ordinamento comunitario.
Il punto che ha originato il contrasto riguardava la corretta applicazione ed il successivo vaglio giurisdizionale del principio di proporzionalità nell’ambito dell’azione posta in essere dalla BCE: a parere dei giudici tedeschi il corretto esercizio del potere avrebbe potuto astrattamente produrre anche effetti indiretti di politica economica, tuttavia tali effetti indiretti avrebbero dovuto dimostrarsi proporzionati rispetto all’obiettivo perseguito nell’ambito delle politiche monetarie (stabilità dei prezzi, ed in particolare agevolare l’incremento del tasso di inflazione percepito all’interno del mercato comune per avvicinarlo al livello del 2%).
La posizione della Corte tedesca partiva dall’assunto che: non potranno mai considerarsi indiretti, e quindi astrattamente valutabili (ex post) proporzionati, quegli effetti che sono conseguenza certa od anche solo prevedibile (ex ante) della misura, potendo ritenersi tali (e quindi astrattamente proporzionati) gli effetti collegati a fasi intermedie (e quindi non prevedibili) della misura.
Nei limiti in cui – secondo questa prospettiva- l’effetto di politica economica generato dall’intervento di riacquisto sul mercato aperto dei titoli di debito dello stato sovrano, nella specie l’abbassamento del tasso di interesse del titolo emesso dallo Stato membro sul mercato primario, poteva considerarsi prevedibile, come anche la Corte di Giustizia UE riconosce, il potere deve ritenersi esercitato ultra vires.
Ciò risulta essere niente altro che la concreta traduzione in termini giuridici, applicata al sistema di regole dell’ordinamento comunitario, delle più estrema definizione di politica monetaria restrittiva, come si trova riportata nei manuali di economia politica.
Detto assunto non veniva comunque in alcun modo condiviso dalla Corte UE, né, a dire il vero, sviluppato; la Corte si limitava ad una valutazione in termini di proporzionalità dell’intervento, all’esito della quale la politica di intervento veniva ritenuta conforme alle regole del Trattato e della disciplina normativa comunitaria.
Nel fare ciò, tuttavia, secondo la Corte tedesca, lo scrutinio non rispettava né i principi elaborati sul tema (principio di proporzionalità) dagli ordinamenti degli stati membri, né del resto gli stessi criteri elaborati sul principio in precedenti pronunce dalla Corte di Giustizia UE, venendo a mancare, in particolare, per di più, un controllo di effettività (indagine concreta sui risultati distorsivi prodottisi sul mercato primario dei titoli del debito sovrano, limitandosi il “vaglio” ai criteri presuntivi esplicitati ex ante negli elaborati della BCE).
La Corte tedesca ha poi riconosciuto che non rientri nei suoi poteri quello di sostituirsi ai poteri che il Trattato riserva in via esclusiva alla Corte di Giustizia, ed anche per tale considerazione, nella statuizione finale si rivolge in maniera vincolante nei riguardi di Parlamento e Governo chiamati a vigilare, nel rispetto del mandato costituzionale ricevuto dal corpo elettorale e ricercare ulteriormente conferma nell’effettivo esercizio dei poteri ultra vires della BCE, fino ad arrivare, eventualmente, nel caso, ad imporre alla Banca Centrale Tedesca di cessare nel dare attuazione e/o di collaborare nel programma di acquisti, con il rischio di innescare un conflitto istituzionale fra Stato nazionale ed ordinamento comunitario.
Non è di interesse, in questa sede, soffermarsi sui contrasti di definizione e dei limiti di intervento di politica monetaria, tra l’ordinamento comunitario e l’ordinamento tedesco, così come ricostruiti nei corpi delle pronunce, potendosi rimandare tale approfondimento, di particolare interesse, ad una successiva analisi a ciò dedicata, stante la complessità di inquadramento.
Ciò che interessa rilevare per il momento è la gravità del contrasto giuridico, contrasto che sarebbe in grado di aprire di per sé una crisi nell’ambito dello stesso processo di integrazione a livello comunitario, con esiti difficilmente prevedibili.
Non è questa la prima volta, a dire il vero, che una Corte Costituzionale di uno Stato membro esercita il c.d. “ultra vires review”, si rinvengono almeno tre precedenti: una sentenza della Corte danese nel dicembre 2016, una della Corte slovacca (2005) ed una della Corte ungherese (2004). La Corte Costituzionale italiana, invece, non ha mai esercitato tale tipo di verifica.
Tuttavia, l’eco e la portata della pronuncia del 5 maggio, assumono un connotato di ben altro rilievo, ciò trova conferma nell’eccezionale reazione proveniente dalla stessa Corte Lussemburghese, la quale ha diramato un immediato comunicato con cui si chiariva che: “come le altre autorità degli Stati membri, le corti nazionali sono tenute a garantire la piena efficacia del diritto dell’Ue. Ciò comporta che la pronuncia pregiudiziale della Corte è vincolante per il giudice nazionale, chiamato a prendere la decisione nel procedimento principale (Sentenza della Corte del 14 dicembre 2000, Fazenda Publica, causa C-446/98, punto 49. Le divergenze tra i tribunali degli Stati membri, in merito alla validità di tali atti, potrebbero, infatti, mettere a repentaglio l’unità dell’ordinamento giuridico europeo e minare la certezza del diritto (sentenza della Corte del 22 ottobre 1987, Foto-Frost causa C-314/85, punti 15 e 17) ed é l’unico modo di per garantire l’eguaglianza degli Stati membri nell’Unione che hanno creato” (comunicato stampa Corte di Giustizia n. 58/20 del 8 maggio 2020).
Il comunicato della Corte di Giustizia sembra sottolineare la potenzialità distruttiva che la deroga al principio di esclusività della interpretazione delle norme comunitarie, che i Trattati riservano alla stessa in via esclusiva, può rivestire, per l’intero processo di integrazione comunitario.
La posizione difensiva della Corte sovranazionale sembra attestarsi sul punto che la valutazione sulla corretta applicazione dei criteri interpretativi applicati dalla CGUE eccede i poteri esercitabili dai giudici interni, in ragione, deve ritenersi, di una delega totale di sovranità (che si contrappone in modo evidente alla interpretazione contenuta nella sentenza della Corte tedesca), conferita all’ordinamento sovranazionale dal singolo Stato membro. Ciò che viene messa in discussione, quindi, è la possibilità stessa di esercitare un “ultra vires review”.
Delle due l’una: 1) se si considera la delega di sovranità, esercitata in maniera completa, verso gli organi dell’ordinamento comunitario, non potrebbe rientrare nei poteri delle Corti Costituzionali interne assoggettare ad un sindacato di merito la pronuncia della Corte di Giustizia, dovendo questi limitarsi a recepirla nell’ordinamento interno; 2) se invero la delega di sovranità dovesse ritenersi solo parziale, come affermato dai giudici tedeschi, in ragione e nei limiti delle materie e delle disposizioni dei Trattati, ebbene, in tal caso, ogni singola pronuncia della Corte di Giustizia potrebbe essere sottoposta ad un giudizio di controllo da parte della Corte costituzionale dello Stato membro, per eventualmente dichiararla non vincolante.
Da ciò emerge che con tale sentenza, la Corte costituzionale tedesca ha inteso affermare che il processo di integrazione comunitaria, attuato con l’adesione ai Trattati, non ha comportato una delega totale ed incondizionata di sovranità, soprattutto verso organi dell’ordinamento comunitario del tutto indipendenti dal potere politico (BCE); sovranità che quindi residua in capo agli organi costituzionali come riconosciuti dalla Carta Costituzionale tedesca (Parlamento e Governo).
La Corte di Giustizia, di contro, con il comunicato stampa, ha inteso affermare che, per il suo funzionamento, l’ordinamento comunitario, necessita di una delega totale ed incondizionata di sovranità.